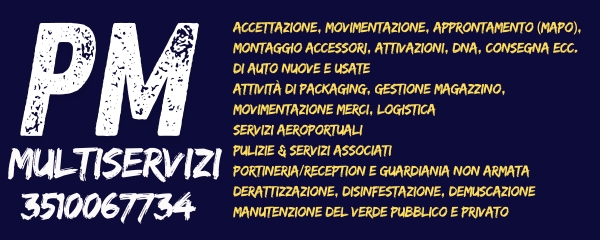Vite spezzate, corpi torturati nel lungo viaggio ad ovest. Storie di diritti mancati fatte di atrocità, umiliazioni, morti, stupri, violenze e discriminazioni. Storie in cui il diritto alla vita non è per tutti. È un lusso! Eppure il diritto di migrare – lo ius migrandi – fa parte di uno dei principi del diritto internazionale.

Il conflitto tra l’Ucraina e la Russia scoppiato nel febbraio 2022, la guerra civile in Siria iniziata nel 2011, la politica repressiva dell’Afghanistan hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare i propri paesi d’origine e a causa di questi eventi si registrano attualmente i numeri più alti in fatto di migrazione. A seguire, poi, troviamo i migranti provenienti dalla Somalia, devastata da una guerra civile iniziata nel 1992, l’Eritrea e l’Etiopia messe in ginocchio da una guerra combattuta tra il 1998 e il 2000 e dai regimi dittatoriali. Anche Iraq, Sudan, Nigeria, Senegal, Ghana e Guinea sono paesi interessati dal fenomeno migratorio. E le vie di fuga prevedono delle tappe obbligate in paesi come la Libia e il Sudan dove in molti casi i migranti denunciano violenze e stupri.
Secondo i dati di Eurostat la popolazione europea è pressoché raddoppiata passando dai venti milioni del 1998 ai quaranta milioni del 2018.
Identificati molto spesso con il termine generico di ‘clandestini’, esistono in verità differenze sostanziali tra rifugiati, richiedenti asilo e migranti. A definire lo status di rifugiato è l’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 identificandolo come colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Il Protocollo del 1967 servì ancor più a tutelare i rifugiati.
Posizione alquanto diversa è quella che identifica, invece, il richiedente asilo che è colui che avendo lasciato il proprio paese d’origine chiede che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato.
Il migrante invece viene identificato come colui che decide di lasciare spontaneamente il paese d’origine in cerca di condizioni di vita possibilmente migliori; potrebbe essere il caso di coloro che scappano anche da catastrofi naturali. Il bilancio catastrofico che ha fatto seguito all’alluvione che pochi giorni fa ha colpito la Libia è l’esempio eclatante di come il climate change stia mietendo non solo migliaia e migliaia di vittime ma anche lo spostamento di migliaia di persone costrette a lasciare i luoghi di origine. Se, poi, a questo aggiungiamo le già preesistenti problematiche quali la siccità, la mancanza di sufficienti risorse idriche, l’instabilità politica e i conflitti etnico-religiosi il quadro diventa ancora più complesso. Secondo i dati dell’ONU si stima che nei prossimi decenni a causa del cambiamento climatico ci saranno 240 milioni di migranti.
Ma i fenomeni migratori affondano le proprie radici in un passato molto lontano nel tempo che coincide con il periodo successivo alla scoperta delle Americhe e il 1820 dove si rintracciano i primi spostamenti più significativi dall’Europa insieme agli schiavi provenienti dall’Africa – e se questi ultimi rappresentavano l’82%, la rimanente parte era costituita da persone appartenenti alle classi sociali più ricche, essendo tali viaggi molto costosi.
Nel XIX secolo, però, si registra un’inversione di tendenza che vedeva i soggetti non schiavizzati ammontare all’81% del totale. Furono 300.000 le persone che tra il 1846 e il 1876 emigrarono dall’Europa andando a inaugurare l’epoca delle migrazioni di massa, favorite dall’avvio del progresso tecnologico, dalla costruzione di nuove linee ferroviarie, dalla riduzione delle misure restrittive all’emigrazione. La carestia che colpì l’Irlanda tra il 1845 e il 1849, poi, completò il quadro, causando un flusso migratorio di mezzo milione di persone. Ed erano gli Stati Uniti la meta più battuta dai migranti, terra di sogni dove come per magia ogni sogno poteva avverarsi proprio come nella canzone New York New York.
Ma ben presto anche l’America del sud e il Canada diventarono mete molto appetibili. Secondo i dati a disposizione nel periodo a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento più di 16 milioni di persone sono espatriate dall’Italia.
Mentre lo scoppio della prima guerra mondiale aveva determinato uno stop alle migrazioni di massa dall’Europa orientale e meridionale ma che continuavano nei paesi anglosassoni e scandinavi, nel secondo dopoguerra in Europa si configurarono nuovi scenari che determinarono negli anni Cinquanta e Sessanta degli spostamenti lungo la direttiva sud-nord e ciò a causa del nuovo boom economico e della richiesta di forza-lavoro straniera. La fine del colonialismo in Asia e in Africa aveva inaugurato seppure tra tante problematiche una nuova epoca, aumentarono infatti i fenomeni migratori verso l’Europa.
Tuttavia, lo shock petrolifero del 1973 e la crisi economica mondiale provocarono una nuova stretta alle immigrazioni insieme ad una significativa riduzione della manodopera straniera. Paesi europei come l’Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia erano ormai diventati punto di accoglienza dei nuovi flussi migratori.
La caduta dei regimi comunisti aveva portato povertà nell’Europa dell’est aprendo la strada alle migrazioni femminili e ciò tra la fine degli anni ottanta e lungo il corso degli anni novanta. Questa nuova ondata di flussi migratori lungo la traiettoria est-ovest è culminata con l’ingresso nell’Unione Europea nel 2004 di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria e nel 2007 di Romania e Bulgaria, favorendo ancor più gli spostamenti.
Ma i flussi più importanti provengono dai paesi extra-europei quali, Africa, Asia e Sud America che vanno a riempire un puzzle sempre più variegato che è quello che conosciamo più da vicino visti anche i fatti degli ultimi giorni che coinvolgono ancora una volta Lampedusa, ormai allo stremo ma che allo stesso tempo si rimbocca le maniche per aiutare come può i migranti che sbarcano sull’isola. È la catena umana di solidarietà ciò che ha sempre contraddistinto il popolo di Lampedusa.
Il 3 ottobre è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione in ricordo di chi a Lampedusa “ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria”. Una tragedia immane avvenuta il 3 ottobre del 2013 al largo dell’Isola dei Conigli, dove un barcone con a bordo seicento persone di nazionalità eritrea si rovesciò provocando la morte di oltre 368 persone e 20 dispersi. Solo 155 persone riuscirono a mettersi in salvo.
Le politiche coloniali del passato ma anche quelle più recenti si sono rivelate fallimentari nel vano tentativo di esportare in Asia e in Africa modelli occidentali configurandosi quindi come parte del problema. Bisogna che ogni stato faccia la sua parte cercando di ammettere legalmente un numero massimo annuale di migranti così da alleggerire un sistema ormai al collasso oltre ad essere crudele e disumano. Il ricorso proposto da alcune associazioni umanitarie francesi in seguito al ‘no’ della Francia agli immigrati è stato accolto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea affermando che i migranti irregolari devono poter “beneficiare di un certo termine per poter lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza”.
Le misure finora attuate che si traducono in un perpetuo rimpallo di responsabilità non fanno altro che esacerbare una situazione che va avanti ormai da anni. Un blocco navale non può essere la soluzione visto pure quello precedente del 1997 finito in tragedia, come pure la militarizzazione del confine italo-francese che ha causato circa 40 morti negli ultimi 8 anni o la costruzione di nuovi centri per il rimpatrio costringendo i migranti a vivere in un limbo per poi essere rimpatriati dopo 18 mesi. Possibile che non abbiamo imparato nulla dalle esperienze passate?
Il problema degli sbarchi ha ormai assunto dimensioni globali e tutti gli stati dovrebbero collaborare offrendo nuove prospettive per il futuro. Bisognerebbe attuare delle politiche di legalizzazione dei flussi migratori e allo stesso tempo risolvere il problema dello sfruttamento lavorativo dei migranti, tutelando i soggetti più vulnerabili favorendo l’alfabetizzazione e proponendo nuove soluzione alloggiative.
Nel frattempo salta l’accordo con la Tunisia. Sarebbe il caso di porci alcune domande!